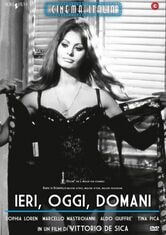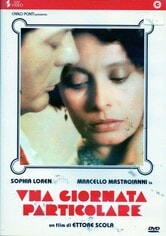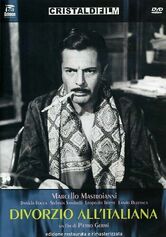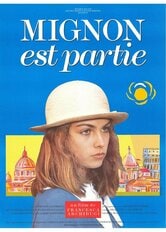Sullo scarto che esiste tra un attore e il suo personaggio sono state scritte pagine e pagine di manuali di recitazione. L’obiettivo, comune a cinema e teatro, è di solito quello di assottigliarlo il più possibile, almeno durante la messa in scena, facendo in modo che persona e personaggio si fondano in un’unica manifestazione, per alimentare la sospensione d’incredulità dello spettatore. Esistono però casi in cui il regista decide di sfidare la sceneggiatura, scegliendo attori che hanno poco o nulla in comune con l’immagine di un personaggio così come l’avrebbe voluta lo scrittore. È accaduto quando Vittorio De Sica, dopo aver deciso di trarre un film dall’opera teatrale Matrimonio all’italiana dell’immenso Eduardo De Filippo, ha scelto Sophia Loren per interpretare la protagonista femminile, Filumena Marturano – che nella stesura originale era affidata a Titina, la sorella del drammaturgo napoletano.

La decisione, che a detta dello stesso De Sica rappresentava un vero e proprio strappo con l’opera di De Filippo, a guardarla oggi sembra in qualche modo aver segnato una soglia epocale: quella tra il cinema italiano del passato e la sua evoluzione futura, di respiro internazionale; quella tra l’atmosfera stantia dell’Italia anni Sessanta, gravida dei rivolgimenti che l’avrebbero attraversata di lì a poco; e infine quella oltre la quale Marcello Mastroianni – che nel film interpreta Domenico, il dongiovanni di cui Filumena si innamora – e Sophia Loren sarebbero diventati un simbolo indiscusso di divismo nazionalpopolare e la coppia più acclamata del nostro cinema.

Nella versione di De Sica, Filumena è bella, giovane, estremamente seducente, premurosa, attenta, dalla personalità travolgente. Praticamente tutto ciò che è stato attribuito a lungo a Sophia Loren, percepita dal pubblico come la materializzazione di una fantasia perfetta, della donna che qualsiasi uomo avrebbe voluto prendere in moglie nel flashback di un’Italia di ieri – quella del maschio cacciatore, della donna come angelo del focolare, di un femminile che, per quanto aperto alla modernità, si vedeva ancora negata qualsiasi possibilità di autodeterminazione all’interno del genere. La protagonista interpretata da Loren è infatti portatrice di un’immagine estremamente moderna, soprattutto a livello estetico, anche se veste i panni della “femmena napoletana”.

L’aria da diva con cui porta i tailleur sotto il ginocchio, i lunghi cappotti e le acconciature cotonate, ammiccano a “quell’italian international style” – un’evoluzione del nostro cinema che lo avrebbe reso vendibile all’estero, individuando (quando non stereotipando) dei marcatori dell’italianità riconoscibili ovunque, e creando la narrazione del nostro Paese nota anche oltre oceano – che De Sica stava abbracciando in quegli anni, abbandonando progressivamente il Neorealismo.
Lo sguardo neorealista, al contrario, viene conservato dal regista nella descrizione degli ambienti del dopoguerra piccoloborghese, nei paesaggi grigi alle falde del Vesuvio, negli interni cavernosi e percorsi da un senso di disfacimento in cui Filumena e Domenico vivono la loro storia.

Ancora, c’e neorealismo nella raffigurazione di una Napoli decadente, che appare come un luogo estraneo e involgarito – tanto che qua e là si sentono canticchiare le strofe nostalgiche di Munasterio ‘e Santa Chiara (“penz’ a Napule comm’era...”). Sullo sfondo della narrazione, infatti, si percepisce il tradizionalismo di un’Italia che probabilmente non era ancora pronta alla ventata progressista che sarebbe arrivata di lì a poco, sconvolgendo gli equilibri sociali del nostro Paese, così come non lo è Domenico. Un solo dettaglio, agli occhi del personaggio interpretato da Mastroianni, macchia infatti l’apparente perfezione di Filumena, rendendola “insposabile”: l’essere stata una prostituta.

Il personaggio di Loren, a partire dal suo passato, incarna quindi un’aperta provocazione: rappresenta, in apparenza, l’archetipo di tutto ciò che risponde al desiderio maschile, ma solo fino a quando tiene nascosto qualcosa di sé. È una figura in contrasto, una perturbazione che svela l’ipocrisia di chi la apprezza finché non si mostra tutta, per ciò che è. Cela quindi una sorta di doppiezza, che non ha tanto a che fare con la sua identità e la sua storia – che invece difende in prima persona con grande fierezza –, quanto con la percezione che gli altri – gli uomini, in particolare, e Domenico su tutti – ne hanno. Questo contrasto è reso evidente anche dal lavoro fatto da De Sica con Loren, nell’affrontare la sfida di trasformare l’attrice com’era allora – spettacolare e trentenne – in un personaggio che alterna bellezza sfrontata e desiderabilità, a tratti consumati e drammatici, e che stride quindi con quella che era la sua immagine pubblica.

Un’operazione di trasfigurazione che, spingendo sulla doppiezza di Filumena, chiarisce l’intenzione profonda del film, che non si limita a indagare un ipotetico desiderio maschile individuale – che potrebbe riguardare al massimo una cerchia ristretta di uomini –, ma ritiene di dare voce a un moto di diffidenza e resistenza al progresso che interessava molte parti d’Italia a metà degli anni Sessanta, un periodo storico che ha rappresentato il preludio alla svolta che sarebbe iniziata con la legge sul divorzio del 1970 – una resistenza che, a ben guardare, risulta inquietantemente simile al riflusso conservatore che oggi riguarda molti Paesi del mondo in tema di tutela femminile, diritti e gender gap. Filumena rappresenta infatti anche una precorritrice delle rivoluzioni femministe degli anni Settanta, dato che è abbastanza risoluta da farsi sposare da Domenico con l’inganno, invertendo le dinamiche di potere tradizionali della coppia.

La sensazione, infatti, è che il regista giochi con i ruoli di genere, attuando un meccanismo autoriflessivo che interroga il maschile più che il femminile, con una domanda che scorre sotterranea alla trama – e che risulta ancora decisamente attuale –: la gran parte degli uomini vorrebbe davvero accanto a sé una compagna da “matrimonio all’italiana” – dunque come parrebbe essere Filumena prima di scoprire il suo passato –, sempre al proprio massimo estetico, servizievole, prevedibile e conforme a tutti i suoi desideri?
A questo interrogativo, che emerge con crescente insistenza nel corso del film oggi rispondono alcuni tra i trend più ricondivisi di TikTok e Instagram, in cui varie influencer propongono il proprio “manuale della moglie perfetta”, autoproclamando l’impeccabilita del proprio modello di femminilità e vendendolo agli utenti come riproducibile in serie. Le “trad wives” – ovvero le “mogli tradizionali”, così come si fanno chiamare le proprietarie di questi profili da milioni di follower – fondano così la propria identità su pane a lievitazione naturale, abiti immacolati, cucine splendenti e altri simboli di uno stile di vita, per l’appunto, tradizionale, ma reso abbastanza moderno e cool da suggerire che, oggi come ieri, la vita è migliore quando le donne aderiscono ai ruoli di genere imposti nella storia.

Al contrario di Filumena, però, queste mogli da catalogo sembrano non avere nulla da nascondere. Anzi, attraverso l’iconografia di un passato idealizzato, ritratto come un’età dell’oro priva di coni d’ombra, cercano di evocare la fantasia economica ed emotiva per cui le donne, rinunciando a un po’ di libertà, possano sottrarsi alla complessità della società moderna. Le “trad wives” rappresentano infatti una soluzione fondamentalmente conservatrice e individuale a uno tra i fallimenti sociali più incisivi del nostro presente, ovvero il sentimento di angoscia bruciante con cui sempre più persone – e non solo donne – guardano alla realtà intricata e spesso incomprensibile che viviamo. Uno stato d’animo che ha portato le mogli tradizionali a rifugiarsi non solo in casa, ma anche nella storia, insinuando in chi le segue il dubbio che questo riavvolgimento del nastro del tempo sia una strada praticabile, senza conseguenze negative per lo stato dei diritti delle donne.

In un contesto che in questo senso potremmo definire di revisionismo storico, in cui la rilettura del passato si fa sia sui social che in politica, Matrimonio all’italiana continua quindi a rappresentare la preziosa testimonianza di un’epoca di soglia: negli anni Sessanta, infatti, l’Italia ha faticato a proiettarsi in un futuro diverso, decidendo nonostante le molte resistenze di stare dalla parte del progresso sociale, grazie soprattutto alle personalità e ai gruppi rivoluzionari che hanno sostenuto questo passaggio epocale. Allo stesso modo, in un momento come quello presente in cui sembra profilarsi una nuova soglia storica, fatta di inquietudini che ci hanno portato a cercare rassicurazioni in un passato conservatore, dovremmo impegnarci a ragionare su che cosa comporterebbe davvero riaverlo indietro per ognuno di noi. Il film di De Sica, soprattutto con il personaggio interpretato da Loren, sembra allora suggerirci che, per decidere da che parte della storia stare, serve capire da che lato sia l’inganno: se in un passato rimasticato e venduto come perfetto, probabilmente solo perché stiamo dimenticando i motivi per cui vi abbiamo rinunciato; o in un futuro che di certo non promette perfezione, ma rivendica una maggiore parità e libertà – come Filumena fa con Domenico.

Altre donne
Ieri, oggi, domani
Commedia - Italia/Francia 1963 - durata 115’
Regia: Vittorio De Sica
Con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Tina Pica, Giovanni Ridolfi
in streaming: su MUBI MUBI Amazon Channel Amazon Video Apple TV Chili
Una giornata particolare
Drammatico - Italia/Canada 1977 - durata 105’
Regia: Ettore Scola
Con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon, François Bard
in streaming: su Apple TV Chili Amazon Video
Divorzio all'italiana
Commedia - Italia 1961 - durata 120’
Regia: Pietro Germi
Con Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Daniela Rocca, Leopoldo Trieste, Lando Buzzanca, Odoardo Spadaro
in streaming: su Rai Play
Mignon è partita
Commedia - Italia/Francia 1988 - durata 94’
Regia: Francesca Archibugi
Con Leonardo Ruta, Céline Beauvallet, Stefania Sandrelli, Massimo Dapporto