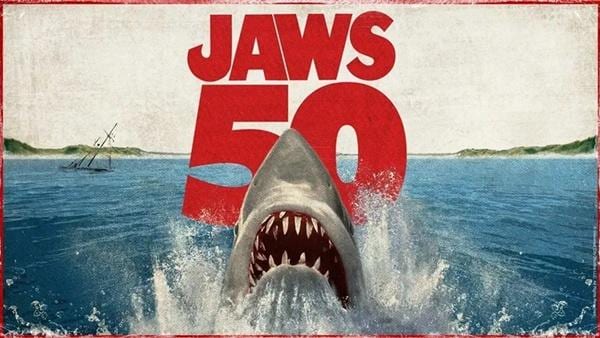
Il vecchio adagio che dice “meglio il libro del film” non vale sempre. Ed è il caso del romanzo di Peter Benchley. Attenzione: non ho detto che il libro è meglio del film, ma che il libro – sviluppandosi in buona parte in modo differente – è una piacevole lettura che ci dice molto altro sull’universo narrativo che ha caratterizzato il nostro immaginario dall’uscita nei cinema nel 1975 di Jaws (Steven Spielberg) fino ai giorni nostri soprattutto durante l’epoca della saga che finisce nel 1984 con Jaws: The Revenge (Joseph Sargent).
Il film di Spielberg è un capolavoro imprescindibile sia a livello narrativo sia a livello produttivo (è stato il primo blockbuster della storia, ha sviluppato e consolidato il concetto di sequel, ha potenziato il film attraverso il merchandising e la pubblicità capillare, etc). Narrativamente il film adotta strategie di racconto che ancora oggi sono fondamentali: dalla struttura ad imbuto de The Birds (Alfred Hitchcock, 1963) alla presenza/assenza dello squalo di Spielberg, il cinema degli animali assassini o eco-vengeance, ha contribuito notevolmente alla modulazione sia delle trame horror che dei thriller moderni e contemporanei e in parte anche dei film di avventura esotica. Quindi il film è indiscutibilmente un capolavoro, geniale nella modulazione narrativa, accattivante ed esemplare nel sistema dei personaggi e nella loro caratterizzazione – aiutata ovviamente da un ottimo cast in stato di grazia – e film dotato di una grammatica registica che ne determina la bellezza visiva.
Il film di Spielberg ha ovviamente moltissimi punti in comune con il libro da cui è tratto, ma come spesso accade nelle trasposizioni cinematografiche, per ovvi motivi di narrazione per immagini e logicamente per adattare il “verbale” al “cinematografico”, vengono fatte scelte diverse e a volte radicalmente diverse dall’originale. In questo scarto troviamo l’aspetto interessante del romanzo di Benchley.
Un elenco analitico di ciò che cambia e resta dal romanzo al film sarebbe inutile e meriterebbe piuttosto un volume o un articolo accademico dedicato a questo. Qui mi limiterò ad elencare rapidamente le principali differenze che poi determinano anche il piacere di questa lettura, soprattutto per chi, come me, conosce a memoria il film che rivede e rivede una volta all’anno e ne ha quindi un culto morboso.
Dimenticatevi battute come “Ci serve una barca più grossa” o il bellissimo monologo di Robert Shaw sull’Indianapolis o l’esilarante filastrocca dello stesso su una certa Mary Succhiei morta all'età di anni centosei, fino a quindici anni rimase illibata, ma da allora in poi non s'era più fermata. Sono, insieme ad altre battute e dialoghi sferzanti ed incisivi, felici invenzioni dello sceneggiatore Carl Gottlieb e dello stesso Benchley.
A parte battute, monologhi e dialoghi, il romanzo ci dice che innanzitutto Amity non è un’isola, ma una cittadina di Long Island situabile nei pressi di Montauk. A pagina 280 dell’edizione italiana del 1974 dopo che l’autore ci dice che sono “al largo di Montauk” leggiamo: “Quando giunsero in mare aperto, diretti a sud-ovest, il beccheggio diminuì. […] Avevano superato il capo [Montauk, ndr] solo da un quarto d’ora quando Quint tirò indietro la leva riducendo i giri del motore. […] «Ho una sensazione.» Quint indicò a sinistra, verso un gruppo di piccole luci, sulla costa. «Là c’è Amity.»”. Da qui si deduce che se sono diretti a sud-ovest, dopo aver girato Montauk Point e Amity si vede allo loro sinistra significa che Amity si trova più o meno nell’estrema punta nord di Long Island – se Amity fosse sulla costa sud di Long Island, dove si trova Ditch Plains Beach per esempio, la dovrebbero vedere alla loro destra (si sa, invece, che nella finzione cinematografica l’isola di Amity corrisponderebbe a Martha’s Vineyard).
Altre differenze non da poco sono le seguenti: Martin Brody è un isolano e sua moglie Ellen invece viene da una delle tante famiglie borghesi di New York che passano l’estate a Long Island, nel film invece – caratteristica fondamentale per il tratteggio del personaggio – Brody viene da New York, odia il mare e odia l’acqua (ma la repulsione per l’acqua è anche un tratto, sebbene poco battuto, del Brody del romanzo [p. 81]); la coppia ha tre figli e non due come nel film, anche se il più piccolo dei tre si chiama Sean proprio come nel film; il miglior amico di Brody con cui in parte affronta la minaccia dello squalo è Harry Meadows il giornalista e direttore del giornale locale The Leader che nel film appare poche volte; tra gli amici di Brody c’è anche l’agente Hendricks, come nel film, e pittoresco proprio come nel film, e addirittura il sindaco Larry Vaughan è amico intimo della famiglia Brody e a differenza del film, pur ostacolando le precauzioni di Brody, emerge un problema legato alla malavita e ai debiti del sindaco che è costretto suo malgrado a tenere aperte le spiagge.
Un aspetto importantissimo del romanzo per comprendere al meglio la sua narrazione e i significati reconditi è che Ellen Brody, pur innamorata di suo marito, si sente frustrata e vive con nostalgia la lontananza dalla vita mondana di New York. Questo “piccolo trauma” la porterà a invaghirsi del giovane ittiologo e oceanografo Matt Hooper arrivato sull’isola per aiutare a gestire l’emergenza squalo, e che è pure il fratello minore del vecchio fidanzato di Ellen: aggancio, link, che aiuta a sprofondare la donna nei ricordi del passato e quindi ad acuirne la frustrazione. Questa carambola di emozioni e coincidenze provocheranno in Ellen il desiderio dell’adulterio che si consumerà con Hooper in una stanza d’albergo.

E da qui parte una linea narrativa che si discosta nettamente dal film: mentre nel cult di Spielberg Brody e Hooper diventano subito amici e si sentono piacevolmente in sintonia mentre intorno tutti gli remano contro (riuscitissimo ritratto di amicizia virile mista a buddy movie), nel romanzo sono continuamente in conflitto e arrivano pure alle mani. Fin dal loro primo incontro si percepisce tensione e rivalità: “I due si strinsero la mano. «Lei è quel tale di Woods Hole» commentò Brody, cercando di scrutarlo nella luce morente. Era giovane, sui venticinque anni, e un bel figliolo: abbronzato, capelli schiariti dal sole. Era alto quasi quanto Brody, circa uno e ottantacinque, ma più magro. Settantacinque chili circa, contro i suoi novanta. E istintivamente cercò di valutarlo come possibile rivale. Poi, con orgoglio da adolescente – Brody se ne accorse – concluse che se mai fossero arrivati a un confronto, lui avrebbe avuto la meglio su Hooper [p. 87]”. E infatti le cose vanno così. Anche se Brody non sa con certezza del tradimento di sua moglie, sa che è successo, lo sente e lo percepisce, e i giorni in barca con Quint deflagrano questa rivalità tutta maschile che si conclude proprio con la morte di Hooper quando scende nella gabbia anti-squalo.
E di tensioni sessuali, conflitti virili, adolescenze varie è seminato il romanzo, più del film. Anzi, l’autore dedica diverse righe proprio agli adolescenti: “Gli adolescenti erano distesi in file compatte, simmetriche: i ragazzi a godersi la sensazione dello sfregare il basso ventre contro la sabbia, pensando agli organi sessuali, e ogni tanto allungavano il collo per una sbirciatina a quelli rivelati, volutamente o no, dalle ragazze stese sul dorso, a gambe larghe” (p. 54). I capoversi a seguire li descrivono nel dettaglio allontanandoli dallo stereotipo dei giovani figli dei fiori tutti pace e giustizia, ma accostandoli ai figli di papà, belli, in salute, ben deodorati e con denti bianchi e dritti: “I corpi erano snelli, con muscoli ben sviluppati da lezioni di pugilato a nove anni, di equitazione a dodici, e di tennis da allora in poi”. Ne emerge un ritratto di ragazzi distaccati dalla realtà ed immersi nella loro ovatta, disinteressati a ogni cosa, cultori dell’estetica e del privilegio. L’esatto contrario del duello virile messo in scena da Brody con Hooper. Quest’ultimo con la funzione di filo diretto con gli adolescenti prima descritti, un loro simulacro.
Nel romanzo troviamo quindi tensione sensuale, socio-classista e anche razziale (non pochi sono i commenti sui neri che servono a dare l’idea del tessuto culturale della cittadina e non sono necessariamente idee dell’autore) che sfociano nella caccia allo squalo, al mostro marino che emerge dal buio degli abissi, all’agente di terrore che sconquassa la quiete della cittadina come quella dei personaggi creando un’ossessione di vendetta nei suoi confronti – ossessione che Brody ha sia per il senso di colpa che lo attanaglia dopo non aver potuto chiudere le spiagge, sia perché riflette sul pescecane – simbolo fallico – la minaccia alla sua virilità. L’ossessione di Quint è invece più simile a quella dell’Ahab di Moby-Dick; or The Whale (Herman Melville, 1851) a cui lo squalo è da subito stato paragonato: un’ossessione cieca, morbosa, una sfida titanica contro dio e la natura che l’uomo vuole addomesticare, ma anche sfida contro il rimosso americano, contro le colpe degli americani che, fin dal 1800, hanno innervato la letteratura dei vecchi inglesi trapiantati nel nuovo continente rappresentando questo rimosso pungolante come l’americano disparente, il pellerossa, il vanishing american di Leslie Fiedler (1968) o anche come una grossa balena bianca a rappresentazione dell’ossessione per la cultura wasp a cui l’uomo bianco, colpevole, dà la colpa.
La vendetta verso lo squalo è esplicitata dall’autore stesso in più punti, ma soprattutto a pagina 96 quando Hooper rinfaccia a Brody che “non può partirsene in tromba a cercar vendetta contro un pesce. Questo squalo non è animato da malvagità. Non è un assassino. Ubbidisce solo ai suoi istinti. Cercare di prendersi la rivincita contro un pesce è assurdo. […] Brody stava andando in collera. Una collera nata dalla frustrazione e dall’umiliazione. […] Quell’animale era un nemico. […] Soprattutto Brody lo voleva morto perché la morte di quella bestia sarebbe stata una catarsi, per lui”. E il cerchio quindi si chiude.

Apostrofato come “leviatano” (p. 113), erede dell’immagine iconica della balena bianca di Melville, lo squalo di Benchley, come quello di Spielberg rappresentano, oltre l’enigma della natura ferina senza una causa (questo squalo, oltre ad avere dimensioni mai viste prima, sui 6 metri di lunghezza, non si comporta come gli altri, sembra animato da un altro istinto non prettamente predatorio, come se fosse emerso dagli abissi proprio per dare lui la caccia a Brody, Quint e Hooper), anche la vertigine per l’ignoto, per tutto ciò che al mondo non ha una risposta, per il male allo stato puro di cui mai se ne capisce l’origine, e contro cui l’uomo moderno tende la sua lotta.
Al netto dei sottotesti sessuali e sociali che si rintracciano nel romanzo di Benchley, come il culto della ricchezza e del profitto, lo spettacolo della morte, etc., è proprio la caccia alle proprie ossessioni, la caccia alla parte buia di ognuno di noi che, paradossalmente qui è bianca come la balena, come il Cane bianco di Romain Gary (1970) e di conseguenza dell’omonimo film di Robert Fuller del 1982, esattamente come il White Buffalo di Richard Sale (1975, guarda caso l’anno di uscita di Jaws) e la sua trasposizione cinematografica diretta da J. Lee Thompson nel 1977 con Charles Bronson, o come il bianco giudice Holden di Blood Meridian (Cormac MacCarthy, 1985), a raffigurare la lotta interiore al rimosso americano che è rintracciabile nella cultura wasp che ha generato tutti i sensi di colpa dell’homo americanus; è questa caccia, in comune con il film di Spielberg, ad essere il principale fattore di successo di questa storia, della sua universalità e della sua intramontabilità.
Merita, in chiusura, l’entrata in scena di Quint alla fine del terzo capitolo della prima parte, pagine 78 e 79: “A dieci miglia a sud della punta orientale di Long Island un peschereccio a nolo avanza lento seguendo la corrente”. A bordo due turisti a caccia grossa e Quint, il capitano dell’imbarcazione, un tipo alto, scarno, che sedeva su una panca del ponte superiore, lo sguardo fisso sull’acqua. Uno dei due turisti gli chiede se potrebbero imbattersi nello squalo di cui tanto si parla e Quint risponde “Macché”. Il tipo continua: “Be’, se si trova qui in giro, magari un giorno o l’altro potrebbe incontrarlo”. E Quint: “Oh, ci incontreremo, questo è sicuro. Ma non oggi”.




Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta